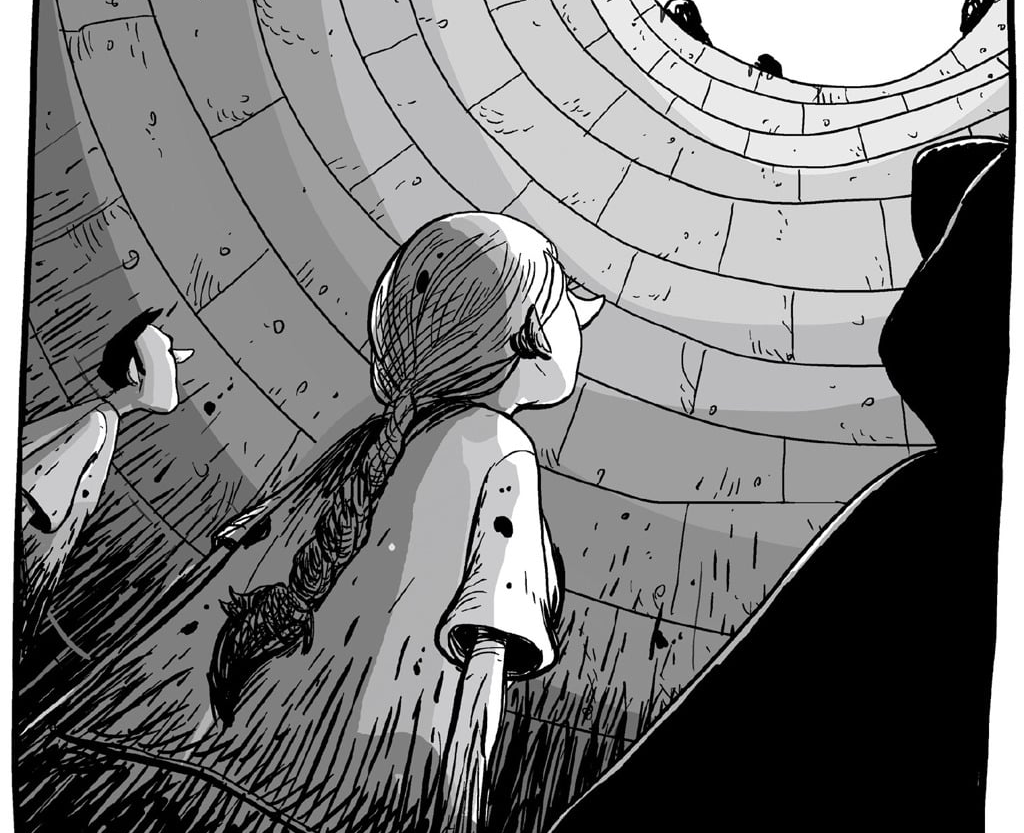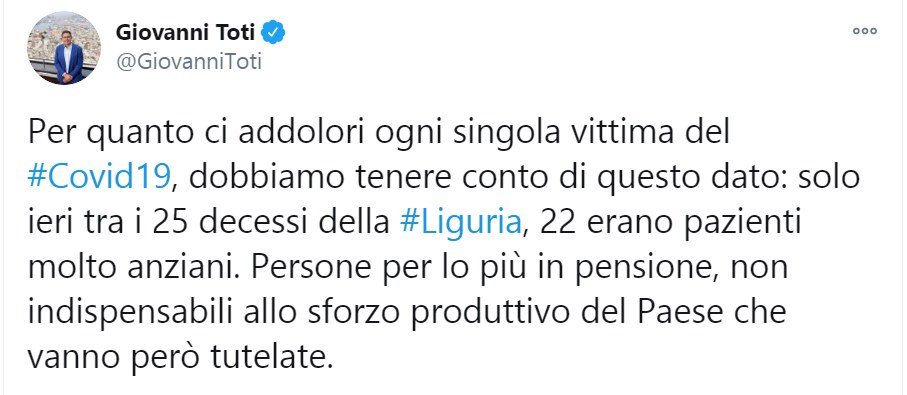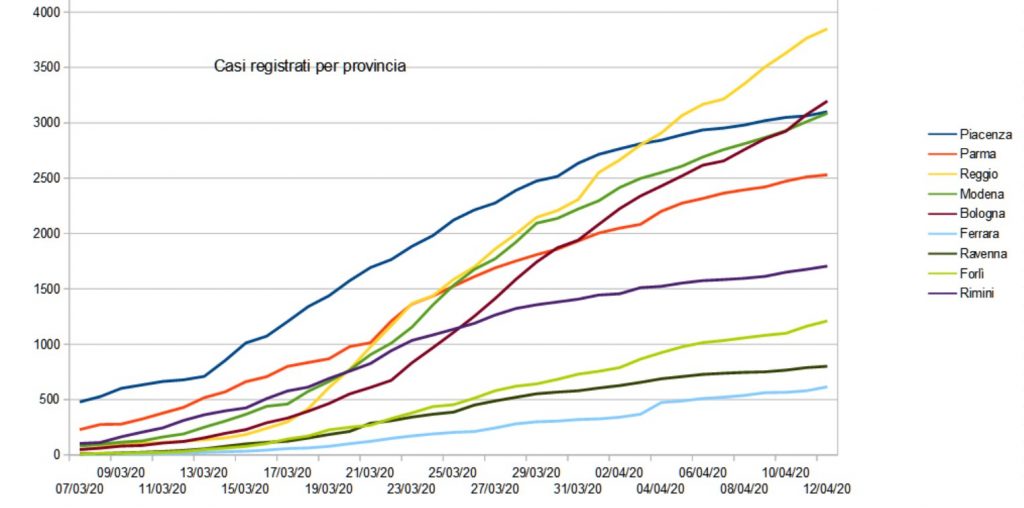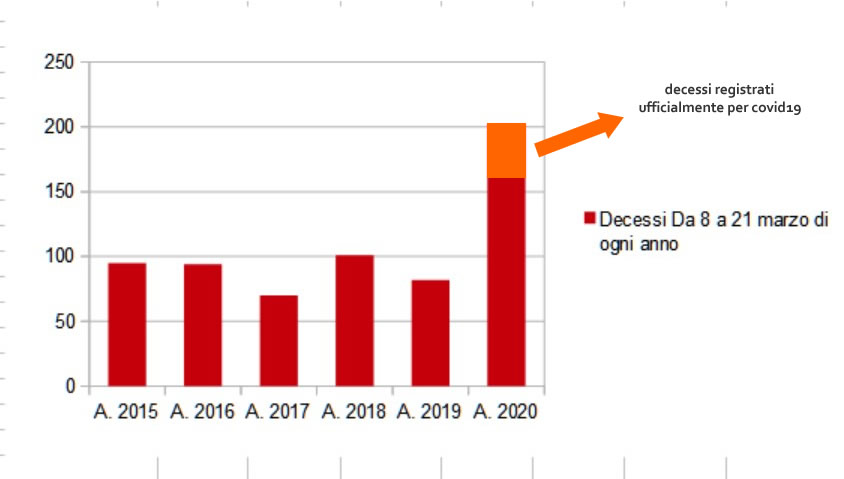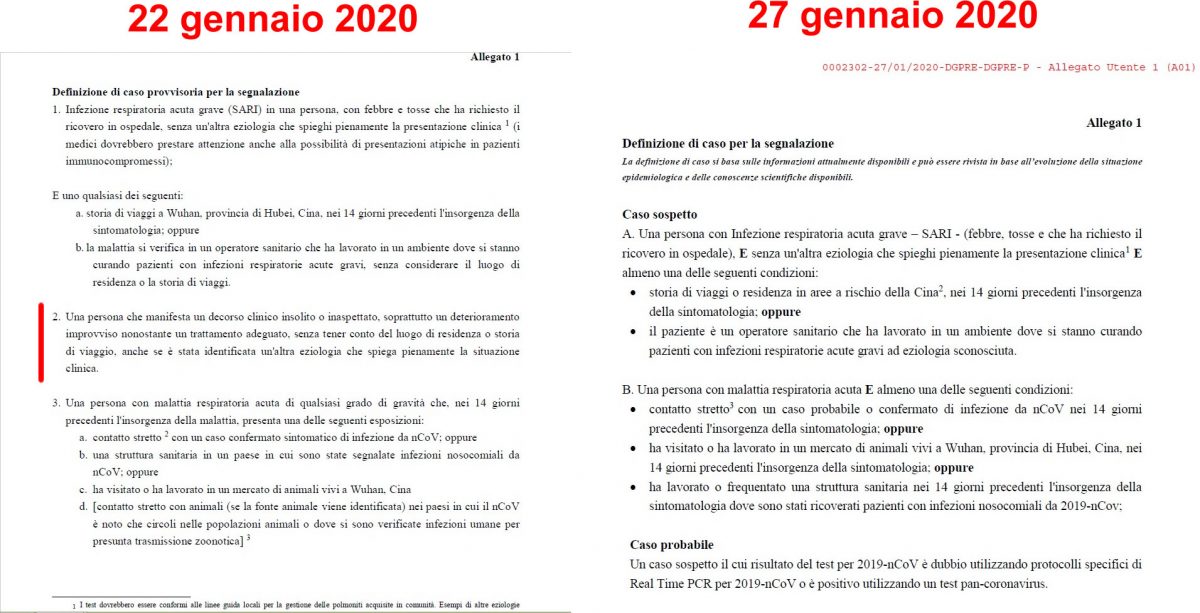Da quindici anni (o qualcosa di più) mi porto dietro una storia, che è poi una piccola storia personale dentro una più grande e collettiva.
E’ una storia che uso come una specie di libretto delle istruzioni, per tentare di maneggiare con cura, due faccende comuni e quotidiane, ma fragilissime e preziose, come la verità e la vita.
La nostra e quella degli altri.
(è lunga, portate pazienza).
David, piacere.
“Ciao, sono Lorenzo”.
Parlammo del più e del meno, del piatto di riso, dei sentieri del Nepal.
Lui scendeva, noi salivamo.Il veloce tempo di un pranzo al sole.
Faccio il giornalista, sono qui per preparare un libro.
Forse conosci il primo che ho scritto. Titolo e mio buio totale.
“Mi ricorda qualcosa in effetti”.
Stavo mentendo con spudorata gentilezza.
Qualche settimana dopo, tornato dall’Himalaya, entro nella Pilgrims Book House, un’affascinante e storica libreria di Kathmandu, purtroppo distrutta da un incendio nel 2013. Il libro di David c’era.
C’era per forza: da un anno era nella classifica dei libri più venduti stilata dal New York Times e ci sarebbe rimasto per altri tre, fino al 2011. Un piccolo record.
Non lo lessi subito. Molte cose si ammucchiavano e per qualche mese lo dimenticai in fondo alla lista delle cose da fare. Poi una sera ho aperto la copertina e ho divorato 350 pagine in un paio di giorni.
Da tempo non leggevo una storia così ispirata e coinvolgente. E se qualcuno, sciaguratamente, mi chiedeva consiglio su qualcosa da leggere dicevo: leggi questo, non te ne pentirai.
Quattro anni dopo il nostro casuale e veloce incontro sui sentieri del Nepal, poco dopo mezzogiorno del 15 novembre 2012, David Oliver Relin si piazza davanti ad un treno in corsa a Portland, Oregon.
Aveva smesso di prendere i suoi antidepressivi.
Da un anno e mezzo il libro che l’aveva reso un autore di grande successo, lo stavo piano piano schiacciando.
Nel 2009 Barack Obama ha vinto, non senza polemiche, il Nobel per la Pace.
Forse ve lo ricordate.
La parte in denaro del premio è stata donata a diverse associazioni no-profit americane. Centomila dollari furono destinati anche al “Central Asia Institute”, una Ong fondata nel 1996 da un ragazzone piuttosto intraprendente e dai modi spicci.
Si chiama Greg Mortenson.
Il nome forse vi dirà poco, ma per quattro anni buoni, Greg Mortenson è stato per l’opinione pubblica americana un eroe.
Un vero eroe.
Un eroe che costruiva scuole. Scuole soprattutto per bambine e ragazze.
Scuole in posti piuttosto singolari per un americano: Pakistan e Afghanistan. Nell’America in guerra con il fantasma di Bin Laden, la strategia di Greg era: “meno bombe, più scuole”.
Nel 2007, nel giro di qualche mese, la sua piccola e quasi domestica associazione con base a Bozeman nel Montana, viene inondata di milioni di dollari in donazioni.
Centinaia di scuole americane aderiscono al suo programma “Pennies for Peace”.
Era l’America profonda, stanca e provata dalla lunga guerra al terrore iniziata da George W. Bush, che cercava una strada diversa verso la speranza.
Ed era l’effetto di un libro di grande successo che raccontava la sua storia.
Sì, era quel libro: “Three cups of tea” (Tre tazze di tè) di David Oliver Relin e Greg Mortenson.
Per caso o per il sottile gioco del destino nella mia libreria era finito a pochi centimetri da un vecchio libro di Jon Krakauer (l’autore di “Into the Wild” e “Aria Sottile”).
Nell’aprile del 2011 “60 minutes” un’autorevole e seguita trasmissione della CBS, attraverso l’inchiesta giornalistica di Krakauer demolì, in un’ora, il libro di David ed in particolare il suo protagonista e co-autore Greg Mortenson.
L’accusa era di aver romanzato o inventato diversi episodi della vita di Greg, di aver ingigantito le opere e l’impatto sociale del “Central Asia Institute”, di aver speso un sacco di soldi per promuovere i propri libri invece di costruire scuole.
Nel giro di una notte Greg Mortenson non sarebbe stato più l’eroe di nessuno.
Sottoposto ad inchiesta, fu costretto a dimettersi da tutti gli incarichi direttivi dell’associazione che aveva fondato e a versare 980.000 dollari, ipotecando la sua casa e rimanendo come semplice dipendente.
Tutti gli incontri pubblici, i seminari, gli inviti e le presentazioni dei libri annullate.
Della figura pubblica di Greg Mortenson, per scelta e necessità non rimase nulla o quasi.
Ho conosciuto Annalisa e il suo sorriso facile una sera di fine settembre del 2011.
Mamma, medico e alpinista, Annalisa aveva appena condiviso con mio fratello l’esperienza sportiva ed umana del Gasherbrum, un ottomila in Pakistan.
Se esiste un mal d’Africa esiste certamente anche un mal d’Himalaya (e Karakorum): una specie d’attrazione fatale, che ti fa dimenticare tutte le fatiche e le privazioni e che prima o poi ti riporta ai piedi di quelle incredibili montagne.
Annalisa ha preso quel male e appena può torna là.
Nel giugno del 2012, mentre si trovava a Skardu sulla via per il ghiacciaio del Baltoro, qualcuno bussa alla porta della sua camera.
Davanti a lei si presentano due uomini e una bambina.
Sakina ha 5 anni, non sorride mai e suo padre dice che fa sempre fatica a respirare.
Annalisa, visitandola brevemente, diagnostica un serio problema cardiaco.
Il secondo uomo nella stanza, quello che accompagna padre e figlia, è un ragazzone un po’ invecchiato avvolto negli abiti tradizionali del Baltistan.
Non è però pakistano, è uno yankee del Montana.
Greg Mortenson, uscito dalle luci dei riflettori e decaduto dal ruolo ingombrante di eroe senza macchia, era tornato a fare quello che più amava: provare ad aiutare gli altri.
Greg, che ha lasciato i suoi incarichi con il “Central Asia Institute” per dedicare più tempo alla famiglia, è una persona fuori dall’ordinario, con tutto quello che comporta nel bene e nel male.
In 30 anni ha fatto molto per l’istruzione e per la pace.
E insieme a questo “molto” ha commesso un sacco di errori.
E’ sopravvissuto, anche fisicamente, a quegli errori.
Ma non tutti sono Greg.
Qualcuno è anche David.
Nel 2012, pochi mesi dopo la prima visita, Annalisa ha raccolto i fondi per far operare Sakina in Italia.
Oggi è tornata in Pakistan e grazie ad una raccolta fondi dall’Italia nel 2022 ha iniziato le scuole superiori.
Annalisa e Sakina si sono riviste di persona nel 2023, dopo dieci anni, in una piccola stanza di un ostello di Skardu davanti ad una pizza.
Hanno sorriso e si sono abbracciate.
Perché la vita come la verità è una faccenda di tutti i giorni, fragilissima e preziosa.